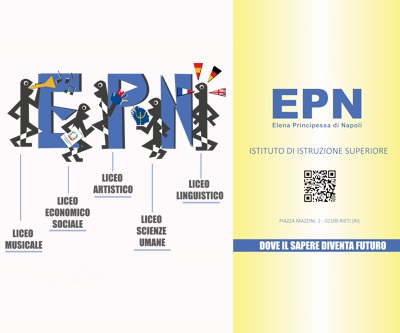Sergio Rigliani è nato due volte. Ha una coppia di date vicine che si contendono l’importanza. La prima volta è nato a Rieti, in via Bevilacqua, vicino Porta Conca, il 14 luglio del 1941, la seconda è successo al Policlinico di Roma, il 19 luglio del 1943, sotto la pioggia delle bombe statunitensi che presero di mira il vicino quartiere di San Lorenzo, in braccio a mamma Ersilia, con le bende agli occhi.
Era lì per curare una brutta infezione agli ossi facciali, il piccolo Sergio. Un’infezione che rischiava di compromettere la sua vista. L’aveva presa succhiando pezze di stoffa, usate allora come ciuccio. Aveva subìto da poco un delicato intervento chirurgico. Ed era sul punto di nascere una seconda volta, poco dopo le undici di mattina: tra i rumori assordanti delle sirene, gli scoppi, i boati terrificanti. Nella confusione generale la benda di protezione scivola via e dopo un po’ lui riesce a mettere a fuoco tutta quella desolazione: i vetri delle finestre esplosi, una suora vestita di bianco che prega lungo la corsia, il signore con la gamba ingessata che grida perché qualcuno lo aiuti a fuggire, i lucernari che tremano. Poi il crollo.
“Sono immagini impressionanti – ricorda Rigliani, docente di Educazione fisica in pensione, con una brillante carriera da ginnasta alle spalle – si sono conficcate come schegge nella memoria, nonostante avessi appena due anni. I miei genitori mi ripetevano che in fondo ero troppo piccolo per ricordare, che quelle dovevano essere solo suggestioni legate ai racconti appresi dalle loro voci. Invece io quelle immagini le ho stampate dentro. Tutte. La grande fortuna mia e di mamma fu quella di riuscire ad abbandonare il padiglione evitando i crolli che hanno interessato l’ospedale. Così, scossi ma illesi, riuscimmo ad uscirne”.
Roma è colpita al cuore: migliaia di bombe da un quarto di quintale l’una la feriscono dapprima su obiettivi mirati, come lo scalo ferroviario di San Lorenzo o gli aeroporti di Centocelle e Ciampino. Ma il fumo delle esplosioni rapidamente si espande sopra la città, rendendo approssimativi i sistemi di puntamento dei bombardieri B17. Arrivano altre cinque ondate che non risparmiano la Città universitaria, l’Istituto Superiore di Sanità, la cattedrale di San Lorenzo, il cimitero del Verano, l’acquedotto Claudio, il carcere minorile, l’orfanotrofio di via Sabelli. Si conteranno circa tremila vittime, oltre diecimila i feriti. Oscar Rigliani, nel frattempo, a Rieti, sente alla radio il bollettino di guerra.
“Mio padre non aveva ancora compiuto trent’anni – racconta Sergio – preso dalla disperazione andò sotto al Municipio in cerca di Libero e del suo taxi. Non trovandolo, prese la sua bicicletta e pedalò sulla Salaria fino a Roma, zaino in spalla, con qualcosa da mangiare dentro e una bottiglia da riempire nelle soste. Sorpassò carretti carichi di feriti diretti al pronto soccorso. Ci trovò seduti sul secondo scalino del padiglione centrale. Mamma mi aveva coperto il viso con un fazzoletto, per evitare che le ferite dell’intervento si infettassero. Gli andò incontro. Si abbracciarono. Eravamo acciaccati ma felici. Era ormai quasi buio quando tutti e tre ripartimmo in bicicletta per tornare a Rieti. Mamma seduta sulla canna.
Con l’interno dei gomiti, papà la bloccava all’altezza del punto vita, per aiutarla a mantenere l’equilibrio. La bicicletta sbandò un po’, quando lei si accorse delle file ordinate di corpi stesi, sul piazzale del cimitero. Io stavo in braccio a lei, e dopo qualche chilometro ci lasciammo Roma alle spalle, con le sue luci. Papà pedalava nel buio e nel silenzio, tra le file degli alberi in banchina. Non parlava per risparmiare il fiato e non perdere il ritmo. Se prendeva una buca rafforzava la presa, rendeva gli avambracci e induriva i muscoli per recuperare l’assetto. Nelle discese sosteneva mia madre con le ginocchia, perché non scivolasse. Prima delle salite scendevamo e continuavamo a piedi, fino alla fine della pendenza. Era stato un ciclista allenato, un tempo. Ma la fatica e la tensione di quel giorno avevano appesantito le gambe. Aveva mal di schiena, ma andava avanti, in quel buio nero come il fondo di un lago melmoso, col piccolo cono di luce della dinamo davanti a noi. Incontrammo un paio di automobili, ma la luce dei fari durava per il breve tempo del sorpasso. Sulla salita di Torricella, poi, papà sentì chiamare il suo nome: “Oscar!”. Era Libero, il tassista che quella mattina sul presto era partito per Roma, prima dell’attacco. “Salite tutti e tre. Domani ti accompagno a riprendere la bici” gli propose l’autista, insistendo. “Portali a casa”, disse mio padre, affidandoci a lui. Poi si rimise in sella e assestò un altro colpo al pedale, rimettendosi in viaggio”.
Sergio Rigliani ha festeggiato da pochi giorni i suoi ottant’anni con una gran voglia di condividere la sua storia segnata dai tempi della guerra, che lui definisce come “una vergognosa invenzione dell’uomo”. Per la sua famiglia, infatti, l’anno 1943 nasconde altre vicende straordinarie.
“Mio zio Otello dopo l’armistizio dell’8 settembre era a Cefalonia – spiega Rigliani – ed era nelle ultime file di soldati in attesa della decimazione. La sua fortuna fu proprio questa: trovandosi in fondo, approfittò con altri dieci italiani di un momento di distrazione dei soldati tedeschi e usò dei bidoni di carburante e delle palanche come trampolino per saltare fuori dal recinto, fuggendo verso il mare. Solo tre di loro riuscirono a raggiungere a nuoto una barca di pescatori greci che li nascosero poi in uno scantinato per più di venti giorni. Ricevettero un po’ d’acqua e un po’ di pane solo due volte. È stata durissima, per lui, sopravvivere e arrangiarsi per tornare in Italia. Solo che lo Stato per una svista non ha mai riconosciuto la sua versione dei fatti, e zio Otello non figura ancora oggi nell’elenco dei superstiti dell’eccidio di Cefalonia”.
Il 19 luglio rimarrà sempre per Sergio Rigliani il giorno della sua seconda nascita. Quel giorno in cui fu salvato prima dai medici che avevano realizzato un capolavoro di chirurgia, poi da un papà coraggioso, apparso come un angelo in bicicletta, tra le macerie del bombardamento di Roma.
“Conservo un bellissimo ricordo di mio padre – aggiunge – era un tecnico del Municipio di Rieti e gestiva la piscina comunale con molta cura, sin dalla sua apertura. Nei primi anni era una bella novità, ma non tutti i ragazzi avevano i soldi per il biglietto. Li vedevamo appoggiati ai cancelli, guardare all’interno, in silenzio. Con discrezione, quando poteva, papà regalava alcuni ingressi, dando a quei giovani una delle gioie più belle che quel periodo si potessero vivere”.
Stefano Mariantoni
(Ha collaborato Federica Rigliani)